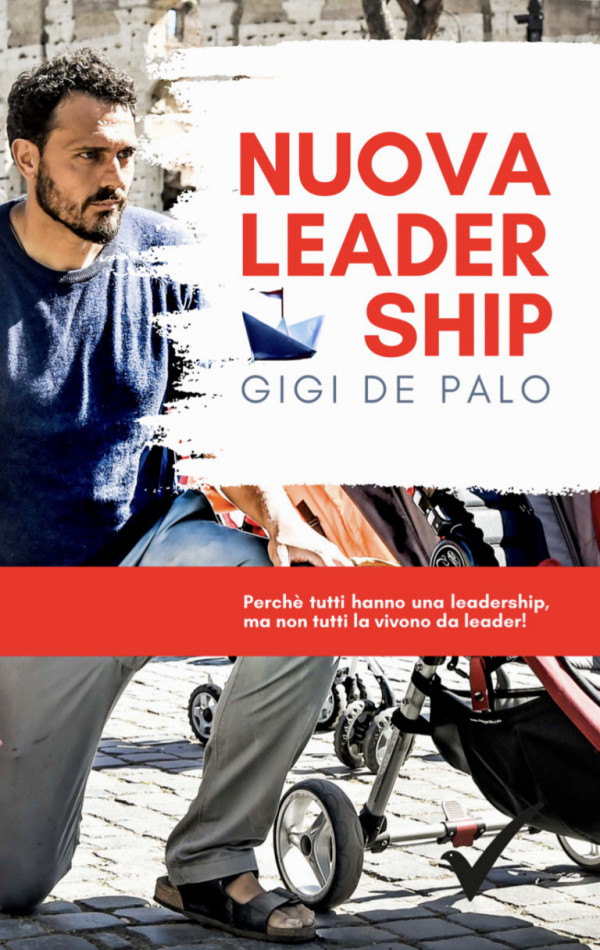Il Paese relegato a giocare sul posto della quotidianità rinunciando a fare goal
È profondamente disumano, ma anche triste, vedere relegato il sociale ad essere una parte e non il tutto che attraversa ogni cosa, ogni politica, ogni servizio, ogni intervento dello Stato, della comunità che si dedica all’uomo.
Cos’è e a cosa serve un’opera pubblica se non viene programmata e costruita per il benessere sociale delle comunità che la vivranno e che la finanziano? Cos’è e a cosa serve un piano urbanistico generale, se non viene elaborato per far star meglio la gente che abita e/o abiterà quel luogo? Cos’è e a cosa serve un programma di eventi culturali, se non viene pensato oltre l’intrattenimento e per lanciare messaggi educativi che orientino la direzione del benessere individuale e collettivo? Cos’è e a cosa serve un giornale, una emittente televisiva, un blog, se non vengono fondati con l’obiettivo di una linea editoriale, della costruzione di un percorso, di un’idea di informazione e quindi di comunità? Cos’è e a cosa serve un libro, una serie tv, un film, uno spettacolo, una produzione artistica, se non nasce per essere proiettata a un obiettivo, diverso dal solo obiettivo di fare pubblico o incassi? A cosa serve la professione e il lavoro, se non ha, parafrasando Calamandrei, una dose di carità, che consente di soprassedere agli errori di programmazione della politica, del proprio sindacato, del proprio ordine professionale, del proprio datore di lavoro, quando in gioco è il nostro paziente, il nostro assistito, il nostro consumatore finale, ecc., quando in gioco è insomma il fine per cui lavoriamo? Cos’è e a cosa serve la democrazia, se il fine di una candidatura, di un programma di governo, di una scelta non si misura con l’obiettivo dichiarato che lo fonda e lo verifica a valle?
Queste domande non sono teoria, sono realtà. Lo dimostrano reparti chiusi perché non ci sono medici a sufficienza nel numero o nella voglia di donarsi; famiglie e imprese impoverite perché l’inflazione si combatte con i manuali impolverati come i cervelli di chi li applica ancora, che dicono di aumentare i tassi di interesse per combattere il caro prezzi; i valzer dei prezzi alle colonnine di carburante che hanno intaccato le tasche dei poveri al pari di quelle dei ricchi, quelle dei lavoratori pendolari al pari dei pensionati, quelle dei petrolieri al pari dei consumatori finali. Parti eguali tra diseguali, direbbe Don Lorenzo Milani, anche se più che evocarlo, ci piacerebbe sentirlo di più nelle parole e nelle opere dei parroci e del laicato, come nei comizi di tutti gli esponenti politici, nessuno escluso, perché è buono chi è umano e chi non è umano non può essere considerato né buono né uomo né “politico” (perché se tutti finalizzano la propria azione alla salvaguardia e al benessere degli esseri umani, c’è un “minimo sindacale” che tutte le forze politiche dovrebbero garantire). Lo stesso è per la qualificazione di “sociale” che dà umanità a ogni cosa e che distingue i mercanti nel tempio, dai fedeli autentici, gli speculatori dagli operatori onesti, la politica che punta a gestire la cronaca da quella che vuole scrivere la storia, chi punta solo a gestire e a proiettarsi sulla realtà, da chi guarda al senso della possibilità.
È questo credo il bivio a cui siamo chiamati, tutti, nessuno escluso. Ormai sembriamo ingessati a giocare la palla sul posto della quotidianità, come un giocatore che ha rinunciato all’obiettivo di segnare un goal (il senso della possibilità). Se nel calcio, un po’ come avviene alla nostra nazionale, il danno risiede nella delusione dei tifosi, quest’atteggiamento per una comunità nazionale diventa una patologia grave che tende ad annientarla.
Per questo ci crogioliamo su un social network anziché misurarci con le piazze e le persone vere, con i circoli e con le sezioni. Per questo mandiamo le armi anziché affrontare la realtà (e la possibilità) di fermare il fuoco, pensando che la guerra così la teniamo lontana, per riscoprirla nella quotidiana esistenza molto più vicina di quello che pensavamo. Per questo affrontiamo la diversabilità e tutte le fragilità con le mani al portafoglio, anziché pensare a cosa davvero serve a un soggetto fragile per stare meglio e, ove possibile, per non esserlo più. Non facciamo più figli per paura del futuro, perché gli spazi e gli agi che ci hanno dato i nostri genitori e i nostri nonni con sacrificio, non vogliamo restituirli alle future generazioni, ma reiterarli anche nell’età in cui la natura e l’approssimarsi delle stagioni ci assegna di farlo, trascurando che la natura ci restituirà una società di vecchi senza l’affetto di chi dovrà assisterli. Questo non cambia solo il sistema di welfare, come ormai si sente dire da tempo, ma prima di tutto le emozioni e i sentimenti della società del futuro.
Siamo chiamati insomma a una sfida epocale che interroga le nostre origini. Senza scomodare (col rischio di divagare) Sciascia o Totò, rappresentando la società per uomini, caporali, mezz’uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraquà, siamo chiamati ad essere umani (e sociali) come individui e nel contributo che come individui diamo alla società, oppure no. La libertà ci garantisce la scelta (libera appunto), ma pure gli effetti sono “liberi” di realizzarsi e la realtà (senza visione e senso della possibilità) ce lo dimostra da tempo!
Foto in evidenza di wendy CORNIQUET da Pixabay