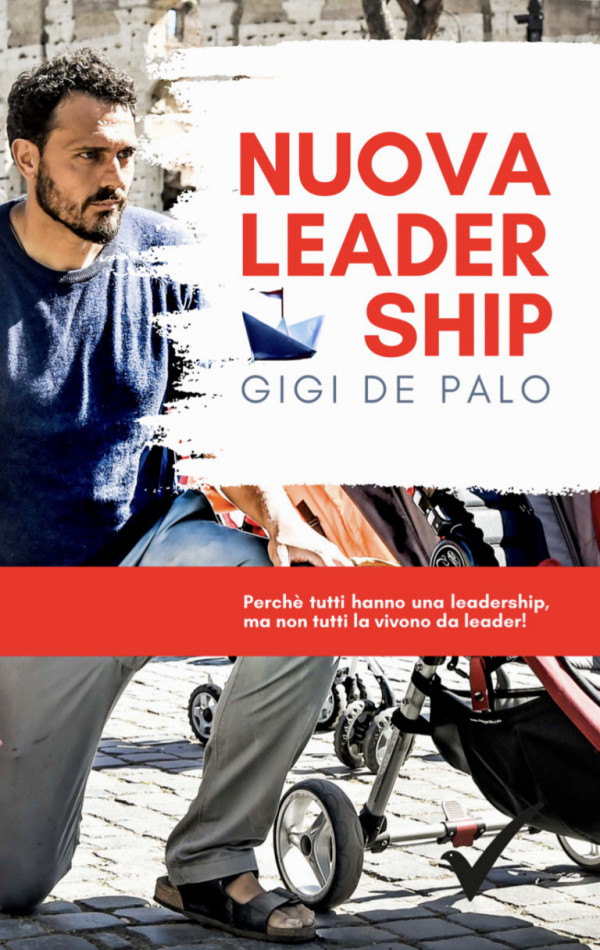In tempi di Recovery, oltre 3 milioni di italiani meritano di essere “recuperati” sulla via dell’integrazione nella società?
Secondo il Rapporto Istat “Conoscere il mondo della disabilità” presentato a fine 2019 (su rilevazioni del 2017), i diversamente abili in Italia ammontano a 3 milioni e 100.000 persone, di cui 1,5 milioni ultrasettantacinquenni. Tra i 15 e i 64 anni solo il 31,5% di coloro che soffrono gravi limitazioni sono occupati (il 49,7% nella PA contro il 41,3% delle persone senza limitazioni). Solo il 65,4% è soddisfatto delle mansioni che ricopre e solo il 19,2% è soddisfatto della vita che vive (contro il 44,5% della restante popolazione). Il 9,3% frequenta cinema e teatri, il 9,1% pratica sport. Sono 272.000 gli alunni con disabilità, il 31,5% le scuole senza barriere fisiche (pur essendo quest’ultime solo una parte delle barriere all’integrazione sociale dei diversamente abili). INPS eroga tra indennità e pensioni 3.233.711 prestazioni monetarie, con un importo medio mensile di 434,09 euro (Dati “Osservatorio sulle pensioni erogate da Inps”, anno 2020).
Questi dati ci dicono di un Paese che risarcisce il diversamente abile e la sua famiglia con prestazioni prevalentemente monetarie (prevalentemente in quanto non si possono sottacere i servizi sanitari e sociali che Stato e Enti Locali offrono), quasi a lavarsi la coscienza, ma è ancora molto lontano dal concetto di inclusione che richiederebbe formule in cui il diversamente abile esprime la sua diversabilità, nei luoghi ordinari della vita di ogni uomo e di ogni donna: la scuola, il lavoro, la società.
Guardando alla scuola, sappiamo che l’integrazione scolastica specialistica è realtà da molti anni, ma conosciamo anche i limiti dell’attuazione di un modello organizzativo dove le istituzioni e i servizi pubblici interessati si parlano (quando va bene), ma non agiscono all’unisono, come se l’alunno sia parcellizzabile tra l’intervento sanitario, quello didattico, quello educativo e quello assistenziale, nonostante i cosiddetti gruppi H di Istituto che, dove si insediano, non rappresentano il luogo vero dell’integrazione sulla persona da includere, da integrare, e non da assistere a compartimenti stagni.
Guardando al mondo del lavoro, siamo consapevoli che nel 1999 con la Legge n. 68 il legislatore ha promosso l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato. I numeri e l’esperienza rispetto all’inserimento lavorativo dei diversamente abili e la concreta attuazione della legge, ci dicono però di una logica da adempimento, fatta di iscrizioni al centro per l’impiego per l’iscrizione nelle apposite liste, di aziende che ottemperano all’obbligo di legge a seguito di ispezioni o comunque prevedendo l’inserimento del lavoratore diversamente abile quantificandolo come un costo da sostenere, di comitati provinciali privi del protagonismo istituzionale che dovrebbero avere promuovendo progetti, raccordando le aziende e le loro associazioni datoriali unitamente alle organizzazioni sindacali, contribuendo a costruire un modello di integrazione dei diversamente abili nel mondo del lavoro e non la cultura della loro tutela attraverso mere quote, spesso non rispettate.
Essere diversamente abile non deve essere un problema per chi vive questa condizione e, per assurdo, finché c’è un modello assistenziale che li riguarda, li faremo sentire esclusi, anche laddove l’assistenza è tecnicamente top. Il tema infatti non è assistere, ma integrare, rendere “normale” una presenza nella società che passa per la rimozione di tutte le barriere a oggi esistenti.
Come per tutti i cittadini, i soggetti non autosufficienti, come ho più volte sostenuto, in generale non usufruiscono di nessuna forma di automaticità delle prestazioni che lo Stato e le sue diramazioni offrono in virtù della condizione fisica e psicologica vissuta, anche se questo rappresenterebbe il minimo sindacale. Ma il tema è un altro.
Come affermato dal presidente Sergio Mattarella in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità del 2019 “Le persone con disabilità rappresentano un giacimento di qualità, energie e risorse di cui il Paese spesso si priva perché non li mette in condizione di esprimerle”. Questa affermazione porta con sé un compito: rivedere il modello organizzativo pubblico che può trovare, negli artt. 56 e 57 del Codice Unico del Terzo settore lo strumento, il paradigma giusto per costruire nella cooprogettazione (da rendere obbligatoria) una presa in carico mirata in cui Stato (nelle sue componenti), organizzazioni sindacali, terzo settore, associazionismo familiare, organizzazioni datoriali sono chiamati a realizzare l’interesse pubblico insito nelle rispettive mission.
Ma si tratta prima di tutto, per dirla con le parole di Papa Francesco, che “occorre sviluppare gli anticorpi contro una cultura che considera alcune vite di serie A e altre di serie B: questo è un peccato sociale! Avere il coraggio di dare voce a quanti sono discriminati per la condizione di disabilità, perché purtroppo in alcune Nazioni, ancora oggi, si stenta a riconoscerli come persone di pari dignità, come fratelli e sorelle in umanità”.
In sintesi, torna il problema del Paese diseguale. Un Paese diseguale che non può dirsi che non spenda per il più fragili, ma la cui qualità della spesa non è coerente con i principi per cui è stata stanziata, abituando la popolazione a lottare per standard economici, quando la prestazione economica su cui è improntata molta parte delle politiche per la non autosufficienza, non solo non basta, ma è molto spesso inutile.
In tempi in cui va di moda la cultura del recovery, oltre 3 milioni di cittadini italiani, meritano di essere “recuperati” sulla via dell’integrazione nella società?