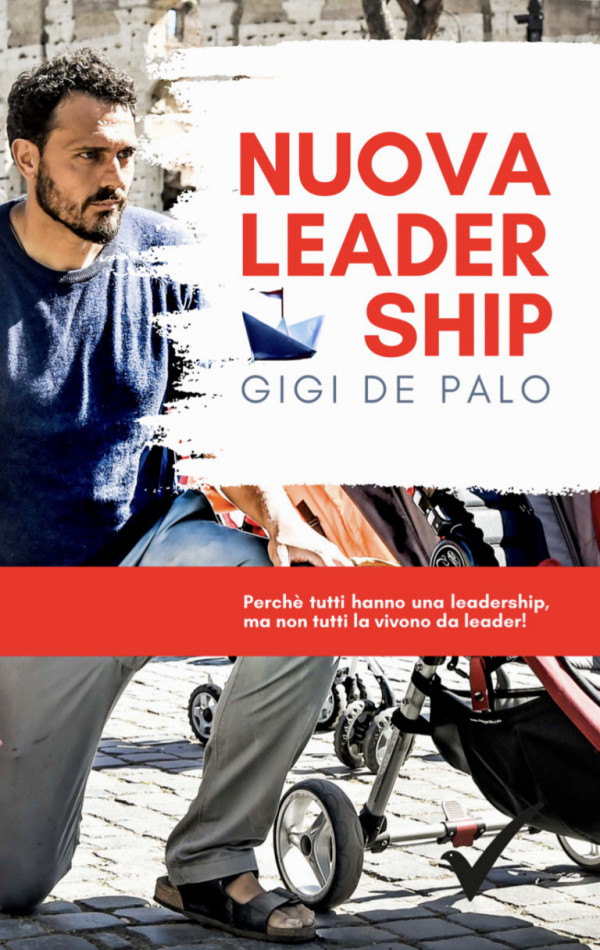E se la fragilità non fosse così come ce la raccontano?
Siamo stati abituati a ritenere (e così la società ci ha educato) che un soggetto fragile sia debole e, in quanto tale, meritevole di essere assistito, coccolato, incluso.
È stato così per i malati, per i diversamente abili, per i disagiati.
Chi ha incontrato un soggetto fragile in carne ed ossa, sa bene però che non è assolutamente così.
Chi ha una fragilità ha anzitutto una forza che gli altri non hanno. È privo di barriere, ha freni inibitori naturalmente assenti o deboli, ha una carica di autenticità che nessuno altro può avere. Questo rende speciale il rapporto con chi ha il privilegio di entrarci in contatto e in sintonia. Spesso la stessa persona, prima e dopo un trauma, prima e dopo una disabilità, prima e dopo aver scoperto una malattia quasi si trasforma, mentre il corpo spesso si deforma. E questa trasformazione mette a nudo aspetti profondi della natura umana che per noi credenti sono il manifestarsi di Dio e della sua grandezza, attraverso l’uomo che soffre; ma anche il laico più oppositivo, ateo e conflittuale, non può però negare che l’incontro con la fragilità (anche la propria) si rivela molto più ricca dell’ordinaria vita quotidiana di ognuno di noi e libera nella sofferenza una felicità piena che dà senso all’esistenza individuale e collettiva. Individuale, quando il “fenomeno” si limita nei confini di noi stessi, collettiva quando facciamo della nostra esperienza di contatto con la fragilità un momento di condivisione, di contaminazione, di diffusione: l’esperienza individuale diventa così impegno sociale, che moltiplica, non somma, non sottrae e non divide. Un tempo quest’ultimo compito lo assolvevano i corpi intermedi, i partiti in particolare; oggi l’unica fragilità che rappresentano è quella dei programmi elettorali e politici, che rasentano l’ovvietà, quando non offendono l’intelligenza del popolo e, la misura dell’offesa, è nel livello calante e progressivo di affluenza alle urne.
Il discorso non è neanche privo di scientificità come qualcuno potrebbe obiettare.
Come è più noto a chi vive il servizio sociale, anche in medicina esiste una branca definita di medicina narrativa (in dottrina NBM, narrative-based medicine”) che permette di esplorare l’esperienza individuale attraverso il racconto sia dei medici sia dei pazienti. Il racconto è di già cura e metodo per quanti si trovino a dover prestare orecchio alla voce della fragilità, come magistralmente Arthur W. Frank ne “Il narratore ferito. Corpo, malattia, etica” scolpisce quando parlando della malattia (e noi potremmo estenderlo alla fragilità in generale) e del suo prolungamento grazie ai progressi della scienza, evidenzia come la permanenza nel regno dello star male richiede di arrivarci preparati, facendo tesoro di chi ci è già stato e con l’occhio ai punti di forza delle stesse fragilità. Curare con la lente di chi narra e delle storie, per liberare soluzioni ed energie. Tale scienza ribalta notevolmente il concetto di debolezza, di fragilità, educando all’approccio al fragile non come l’approccio al debole, ma al diversamente forte che rimette alla pari e in equilibrio la società in cui viviamo.
Il discorso non è neanche privo di concretezza come qualcun altro potrebbe eccepire.
Si pensi al successo di marchi come “Made in carcere” o il più recente da me ideato “Made in Fragilità”. Dei veri e propri brand, inimmaginabili fino a qualche tempo fa quando la fragilità veniva necessariamente associata all’assistenza (o all’assistenzialismo) e mai al riscatto. Quando una fragilità diventa cooperativa, impresa sostenibile, tra ex reclusi, tra diversamente abili, tra beneficiari del reddito di cittadinanza e un marchio ne celebra la forza che i cd. fragili hanno sprigionato a fronte di una presunta debolezza nell’immaginario collettivo, l’obiettivo raggiunto è duplice: la condizione di fragilità è cessata, ma sarà cresciuta anche quella di sicurezza che i cittadini allo stato non fragili avranno, sapendo che esiste una via per ripartire o comunque per vivere meglio le avversità della vita, proprio come nel malato che narra ferito, spesso non tanto per sé (essendo condannato a un triste epilogo), ma per chi, oggi sano, domani potrebbe non esserlo. Come avviene del resto in sanità con la presenza degli ospedali che, anche ove fossero privi di pazienti, svolgerebbero il ruolo sul versante della sicurezza sanitaria, che non è da meno a quello della concreta cura.
Ma su questi paradigmi dov’è il decisore politico? Questi temi, che smonterebbero ogni tifoseria politica ultrà, dove sono nei programmi elettorali? La domanda sorge spontanea: ma educare al riscatto e alla forza della debolezza, forse cambierebbe il nostro sistema di governare il centro e la periferia del nostro Paese? Di converso, educare alla debolezza nella fragilità (e all’assistenzialismo), e schierare ad esempio i pro reddito di cittadinanza e i contro tale misura di contrasto alla povertà, non favorisce un consenso distratto dai problemi reali delle persone e pertanto conviene a conservare la casta dei mediocri? La condanna ad essere marginali perché fragili e irreversibilmente deboli, non alimenta il partito trasversale di chi trova più facile elargire “aspirine sociali”, rispetto a chi vuol guarire il malato e la società, non sapendo fare altro e costringendo a un metro di selezione della classe dirigente a sua immagine e somiglianza?
Foto in evidenza di Armin Rimoldi: Pexels